
Mi perdonino i linguisti per il modo superficiale e probabilmente impreciso di trattare l’argomento con l’intento di renderlo più accessibile al maggior numero di persone possibile.
Partiamo con un esempio. E partiamo dall’italiano, su cui tutti ormai siamo più ferrati.
Prendiamo come esempio tre parole: deNte, fuNgo, aNfora.
Perché ho scritto la N maiuscola? Perché è su quella che voglio soffermarmi. Provate a pronunciarle e a concentrarvi sul suono emesso e sulla posizione della lingua mentre pronunciate la N.
Vi accorgerete che, in realtà, le tre consonanti che pronunciamo sono tre consonanti diverse. Prima della T, la N è pronunciata con la lingua dietro ai denti, il suono della N che precede la G si forma in gola (nel velo del palato), e quello che precede la F si forma sul labbro inferiore. Foneticamente sono tre consonanti diverse. Nell’alfabeto fonetico internazionale sono indicate con tre simboli diversi: n, ŋ, ɱ .Fonologicamente, si tratta della stessa consonante. La scriviamo con lo stesso simbolo N. E la maggior parte delle persone la percepisce come consonante unica senza rendersi conto di avere tre pronunce diverse. Non serve diversificare graficamente perché la fonetica diversa è automatica. Prima della T, dalla D, o in posizione intervocalica o iniziale di parole saremo nel primo caso. Prima della Q o della C e G dura la pronunceremo come nella seconda ipotesi, prima della V e della F ci ritroviamo nel terzo caso. Sempre. E la morfologia delle parole ci aiuta a capire che la fonologia è una sola. Se prendiamo, ad esempio, il prefisso “con-”, presente in tante parole con la stessa valenza, pronuncerò infatti “condividere”, “coŋcatenato”, “coɱfigurare”.
In alcune varietà del dialetto reggiano ci sono casi analoghi che riguardano le vocali.
Per esempio la lettera ê (in reggiano è il simbolo assegnato al suono aperto e lungo) diventa più aperta quando compare prima della R. Ed è sempre più aperta. Se le parole “mêdra”, “brêva”, e “sêl” si pronunciano [‘mɛ:dra], [‘brɛ;va] e [sɛ:l], “sêrta”, “gêra” e “mêr” si prounciano [‘sæ:rta], [‘ʤæ:ra] e [mæ:r].
La maggior parte dei reggiani, specie nelle varietà precollinari, non si rende conto di pronunciare queste vocali più aperte, esattamente nello stesso modo con cui la maggior parte degli italiani di tutte le varietà regionali non percepisce i vari modi di pronunciare la N.
Anche in questo caso ci sono esempi nella morfologia delle parole che evidenziano la valenza identica di questi suoni. Se il verbo “lAvêr”, lo coniugo “ä lêv”, il verbo “sAltêr” lo coniugo “ä sêlt”, il verbo “spArêr”, lo coniugo “ä spêr”… e pur pronunciandolo aperto [spæ:r] è evidente che si tratta della stessa A latina. Se faccio alterazioni delle parole che contengono “ê”, questa diventerà una “a” atona: brêva → br*a*vòuna, br*a*vtèina. Gêra → gi*a*rlèina, gi*a*ròun.
In molte varietà sotto la via Emilia e nella parte ovest della provincia però la pronuncia della ê prima delle consonanti diverse da R è più stretta. In molti casi si ha una E intermedia semichiusa [e̞] che continua ad essere differenziata dalla vocale chiusa vera e propria [e], mantenendo la coppia minima “la s lêva” (si lava) vs “la s lēva” (si alza, si eleva). Ma in alcune varietà si arriva alla fusione completa col suono chiuso, perdendo la coppia minima. I parlanti di queste zone ovviamente perdano la percezione di ugualianza tra vocali molto più distanti e molti finiscano per sentire la ê di “la s lêva”, più simile a quella di “la s lēva” che non a quella di “la spêra”, anche quando non c’è fusione completa.
La differenza fonologica però rimane. Le parole in cui la ē è fonologicamente una e chiusa non cambiano mai questa vocale in A nelle alterazioni o coniugando i verbi. Anche chi pronuncia “la s lēva” per dire “si lava”, se passa al futuro dice “la s lAvarà”, distinguendolo da “la s alvarà”.
Na petnêda, diventa na petnAdèina (anche se la ê la pronuncio chiusa), mentre na “prēda” resta na “prEdlèina” (non pradlèina), come succede invece ai derivati di “prê” (prato) che pure nelle suddette varietà è pronunciato con vocale chiusa. Nei casi di fusione completa quindi stavolta si tratta di due vocali foneticamente uguali, ma fonologicamente diverse.
Denis Ferretti, 15 Luglio 2021
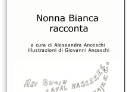

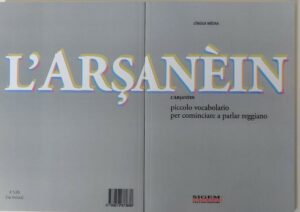

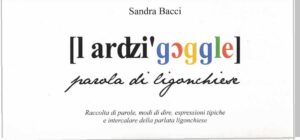


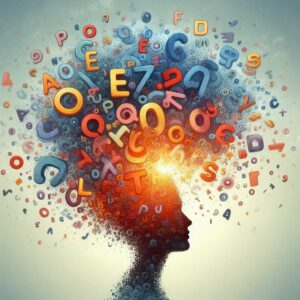
2 risposte
Veramente interessante. Bellissimo sito, complimenti ai redattori e a coloro che contribuiscono ad arricchirlo. Vedrò di farlo conoscere!
Grazie di cuore per il feedback.
La nostra più grande soddisfazione è vedere che il nostro impegno è apprezzato dai lettori.