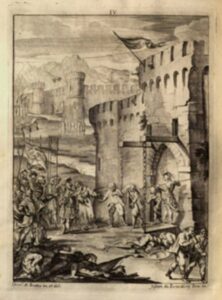Nel mese di giugno la data più significativa legata alla tradizione locale è
sicuramente il giorno di San Giovanni. O meglio “la notte” di San Giovanni, che in realtà rappresenta il solstizio d’estate, ovvero il punto massimo delle ore di luce e ripropone da un punto di vista opposto i riti e le tradizioni del Natale da cui è separata de sei mesi esatti.
Le tradizioni legate a questa festività sono antichissime e pagane. Risalgono al periodo precedente l’occupazione romana, quando sul nostro territorio erano presenti popolazioni di origine celtica, che furono dapprima assoggettate all’impero
e poi, con l’avvento del cristianesimo, convertite alla nuova religione di stato.
Quando il cristianesimo si sostituì alle religioni pagane preesistenti, la politica generale fu quella del rispetto delle tradizioni antiche e del minimo impatto sulle usanze locali a cui si assegnò solamente un valore diverso. Così come la preesistente “festa del sole” del solstizio d’inverno divenne Natale, nella notte di San Giovanni convergono le tradizioni che esaltavano i poteri della luce e del fuoc tipiche di tutte le culture precristiane fin dalla notte dei tempi. Nel giorno più breve
dell’anno secondo il folclore (il solstizio astronomico in realtà è il 21 giugno), le comunità antiche celebravano riti scaramantici che avrebbero voluto rallentare la discesa del sole e mettere in fuga le tenebre e gli spiriti maligni da esse rappresentati.
San Giovanni nella nostra cultura è un giorno di festa. Tradizionalmente, considerando il periodo in cui l’orto offre il meglio, si mangiano i tortelli verdi, così come a Natale si mangiano i cappelletti in brodo con ripieno a base di carne. Piatti ricchi e costosi, che non ci si poteva permettere tutti i giorni, ma riservati a occasioni speciali come, per l’appunto, la notte più breve dell’anno, in cui si festeggia l’estate e si può star fuori fino a tardi.
Molte tradizioni sono legate alla “rugiada di San Giovanni” che avrebbe proprietà miracolose per tante cose. Forse è proprio per questo “culto dell’acqua” che la Chiesa ha scelto di associare a queste tradizioni il Santo associato al rito del battesimo, dove l’acqua ha un ruolo fondamentale.
La rugiada di San Giovanni arrivò perciò a rappresentare l’acqua del battesimo e le si attribuirono poteri miracolosi e propiziatori. Nel reggiano si raccomandava alle ragazze in età da marito di stare alzate fino all’alba perché essere esposte alla rugiada della notte di San Giovanni avrebbe assicurato loro un buon matrimonio. In altri casi si diceva che la rugiada di San Giovanni avesse altre virtù che andavano dal favorire la crescita di capelli molto belli al mantenimento della virilità. Per i più giovani era spesso una scusa per rimanere fuori più del solito e in tempi in cui la contraccezione era quel che era, spesso andava a finire che la profezia del matrimonio “miracolosamente” si avverasse proprio in conseguenza degli avvenimenti di quella calda notte di festa.
Per quanto riguarda la gastronomia locale, il ruolo di San Giovanni èimportantissimo nella preparazione dell’infuso di produzione casalinga più tradizionale: il nocino. Perché venga perfetto è necessario che le noci prima di essere raccolte abbiano avuto esposizione alla leggendaria rugiada di San Giovanni e proprio questo giorno è perciò il momento esatto in cui devono essere raccolte per avviare il processo di lavorazione che ci fornirà questo squisito liquore (1).
Piccola appendice lessicale: guâsa o roşêda? Due sinonimi che in realtà sinonimi non sono.
Visto l’argomento, colgo l’occasione per spiegare la differenza tra due termini che anche in dialetto oggi tendono a essere sovrapposti. In alcune zone si tende a dire sempre “guâsa” e in altre sempre “roşêda”. Soprattutto nelle città. Nella cultura contadina e nei dialetti più conservativi invece i parlanti erano ben consci della differenza tra questi due fenomeni meteorologici. E’ una differenza, tra l’altro, presente anche in italiano, ma oggi è una conoscenza che appartiene solo ai meteorologi, mentre nella tradizione contadina si trattava di una cosa risaputa a ogni livello.
1 Per un’antica ricetta del nocino si veda:
http://www.dialettoreggiano.net/index_file/alnusein.htm
La rugiada “la si alza” – recita una famosa canzone popolare. In realtà anche la rugiada si deposita, ma siccome si forma a seguito della condensazione del vapore contenuto nell’aria a contatto con le superfici precedentemente esposte al sole, si ha l’impressione che salga dal basso, bagnando l’erba, le piante e le superfici che sembrano respirare, come l’erba, le foglie… ma anche oggetti del tutto inanimati come i tetti e le selle delle biciclette, soprattutto a inizio estate.
La rugiada di San Giovanni, perciò è tipicamente “roşêda” anche se in alcune varietà è impropriamente nota come “guâsa ’d San Şvân”… e ovviamente noi rispettiamo anche le derive linguistiche locali, spesso legittimate da proverbi come questo:
Chi ciâpa la guâsa ed San Şvân al sta bèin per tót l’ân
La “guâsa” vera e propria (guazza in italiano) però sarebbe tipicamente autunnale e, in ogni caso, è dovuta alla presenza di nebbia che quando diventa troppo densa può lasciare sulle superfici uno strato d’acqua così che le cose si bagnano come se piovesse. La “guâsa” bagna molto di più della “roşêda” e dà anche l’impressione di scendere dall’alto. La locuzione “durmîr a la guâsa” significa dormire esposti alla guazza ovvero non avere un tetto sulla testa essendo molto poveri. Condizione che è molto più gravosa nella stagione più fredda e comporta un grande disagio. “Durmîr a la roşêda” farebbe quasi pensare a qualcosa di gradevole, almeno nell’immediato, anche se poi potrebbero esserci conseguenze non sempre piacevoli. “L’amōr e ’l caghèt, chi ’n al prōva ’n al crèd” – diceva mia nonna.
Tralascio la traduzione.
“Roşêda” comunque trasmette un senso di fresco ed è percepita come un
fenomeno positivo, al pari della brezza… fa pensare ai boccioli di rose, ai prati fioriti. La guâsa, al contrario, trasmette un senso di freddo e di fastidio… fa pensare ai reumatismi, al buio, al maltempo. Questo almeno nel lessico molto ricco trasmessomi dai miei nonni che parlavano una variante dialettale di tradizione contadina. Localmente, in zone diverse, potrebbero esserci derive linguistiche diverse che hanno portato alla scomparsa di uno dei due termini o a un loro uso
indistinto.