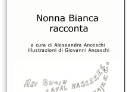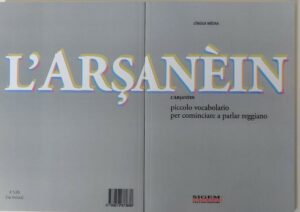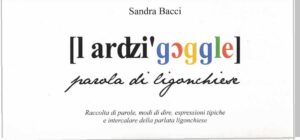Agòst, 2022
I nostri lettori ci perdoneranno se parliamo di due modi dialettali utilizzati per dire che una persona puzza tanto, ma proprio tanto.
Il primo:
pusêr cm’un èndeş
è un modo di dire abbastanza noto, ma da pochi conosciuto per le sue origini, fra i modi di dire reggiani, poiché oggi è difficile imbattersi in un uovo di gallina riconosciuto come èndeş.
Quando le uova erano deposte da galline libere di razzolare attorno alle case rurali era importante distinguere se l’uovo era galê (fecondato) o no (ōv cêr). Per saperlo, si guardava l’uovo in trasparenza e al brêvi reşdōri sapevano distinguere i due casi. Se l’uovo era fecondato lo si faceva covare alla gallina. Diversamente l’uovo poteva essere bevuto fresco o usato per cucinare. Una di queste uova non fecondate veniva messa nella cesta del pollaio per indicare alle galline dove dovevano deporre le uova ed evitare così che le disperdessero in cento posti attorno a casa. Questo uovo messo nella cesta funzionava quindi da “indice” o “endice” (èndeş) e lo si lasciava lì per molto tempo, tanto che a un certo punto marciva. Se disgraziatamente veniva rotto ecco che la puzza d’èndeş si manifestava tutt’intorno con tutta la sua potenza maleodorante.
Meno nota è la seconda espressione:
al pósa cmè un calghêr
Con questo nome calghêr, si indicava il conciatore di pelli, che a Reggio veniva anche definito con un altro termine: cunsèin.
Il conciatore aveva continuamente a che fare con le carcasse puzzolenti degli animali da cui si ricavavano le pelli. L’aria era resa ancor più pesante per l’odore degli scarti di lavorazione e per i prodotti che venivano utilizzati per la concia. La puzza prodotta da queste concerie era così intensa che gli scorzeri, come venivano chiamati i conciatori veneziani , nel 1271vennero relegati a praticare la loro arte sull’isola della Giudecca.
A Reggio invece le concerie erano raggruppate nella Strada di Gallegana, oggi chiamata Via Galgana,(parallela a via San Carlo, che collega via San Filippo con via Toschi) Accanto a questa strada scorreva un canale che alimentava già nel 1445 un molendinum gallae, un mulino destinato a macinare le galle arboree e altri materiali utilizzati nella concia delle pelli. La galla (in dialetto bacócla, o gargâla) è una escrescenza formata dalle piante in risposta all’attacco di un parassita: insetti, batteri, funghi e virus e possono presentarsi in molte forme diverse.

Le bacócla, o gargâla hanno la proprietà di essere anche ricche in tannini, sostanze utili in conceria per il loro elevato potere astringente. E’ possibile, ma non cosa certa, che il nome della strada, oggi via Galgana, provenga proprio dal termine “galla”.
Per i poveri calghêr reggiani la produzione e l’esposizione alla puzza non finiva qui. La Strada di Gallegana nel secolo XIV aveva un vicoletto trasversale che la collegava con via Tavolata, adibito a deposito di letame; non meraviglia dunque che il detto pusêr cme un calghêr sia entrato per questo nei modi di dire dei reggiani.

Può valere però quello che scrisse Fabrizio de André (“dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”): in quella puzzolente strada della nostra città nacque il 10 settembre 1447 Paolo da San Leocadio, il pittore che fece importanti affreschi nella Cattedrale di Valencia, dove morì nel 1520 (circa), che rappresentano scene bibliche, fra le quali la Vita della Vergine che è ritenuta la prima opera del Rinascimento in Spagna).