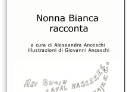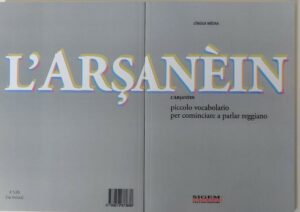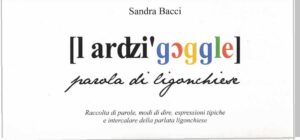Lój, 2022
La rubrica del dialetto reggiano propone questo mese ai suoi lettori un’antica canzone popolare dal titolo La sposa porcaja.
La ragione di questa proposta è molto semplice: un letterato e ricercatore di tradizioni popolari raccolse il testo di questa canzone a Montericco di Albinea e la pubblicò nel 1901. Il testo è purtroppo privo di due versi e ci siamo detti che, forse, qualche famiglia di Montericco potrebbe avere ancora in un vecchio cassetto le parole mancanti e sarebbe veramente un colpo da maestri riuscire a risolvere il mistero.
A questa prima, iniziale, ragione ha fatto seguito la scoperta di una bellissima storia che affonda le sue radici al tempo delle Crociate. Di questa ballata esistono molte versioni diffuse in Provenza, Bretagna, Catalogna, Italia del Nord e, con varianti più marcate, anche nei Balcani e nei paesi slavi, denunciandone un’origine comune.
Il ricercatore di cui si parla è Giuseppe Ferraro, un letterato piemontese, nato nel 1845 a Carpeneto, un paese del Monferrato in provincia di Alessandria. La sua passione era lo studio del folclore delle diverse terre ove dovette trasferirsi per ragioni professionali. Ebbe infatti numerosi incarichi nel campo dell’istruzione che lo portarono a soggiornare in molte città, tra cui Reggio Emilia, negli anni 1890-91. Anche qui raccolse numerosi testi, riuniti nell’opera Canti popolari della Provincia di Reggio Emilia.
Della canzone La sposa porcaja il Ferraro pubblicò tre diverse versioni: una del Monferrato, una seconda ferrarese e quella che qui pubblichiamo nota in terra reggiana.
A g-ho d’ andär ‘la guera Comm’ hò-ja mai da fär?
G-ho na spusletta zovna E qui la tien lassär.
………………………………….. ………………………….
La bela sta sett ani Nè rider nè parlär
Al bell prèm cant chi fò Al so mari al rivò.
Tasì, tasì, me genta Ch’ e possa ben scultär
L’è sta spusletta zovna Ch’ la sa csi ben cantär.-
- Spusletta, la me spusletta Èd chi jen-i ‘sti be’ porc?
- I-jenn dla me’ nonina Ghe psėssa gnir la mort.
- Parė e mo su quei porc Andèmma a la mason,
Quand i sari po’ in càsa Fari vòstar razon.
Màdra, o càra màdra M’ avi fatt un gran tort
‘Vèrgagh sol ‘na norina E mandàrla fora i porc!
[Traduzione]
Devo andare in guerra/ come debbo fare?//Ho una sposa giovane/e qui la debbo lasciare//La bella sta sette anni/ senza ridere e parlare.//Il primo giorno che cantò/ arrivò suo marito//Tacete, tacete miei servi, compagni/ch’io possa ben ascoltare//E’ questa giovane sposa/che canta così bene// Sposa, mia sposa / di chi sono questi bei porci?// Sono di mia suocera/ che possa venire a morte.// Spingete a casa i porci/Andiamo a casa,// Quando sarete poi in casa/ farete (direte) le vostre ragioni.// Madre, o cara madre/ m’avete fatto un grande torto,//Avete in casa solo una nuora/e l’avete mandata fuori a pascere i porci.
[Nota]: ė = suono intermedio tra e e i.
La canzone narra dunque di un marito che parte per la guerra e raccomanda la sua giovane sposa alla madre. Una volta partito, la madre manda la nuora a pascere i porci anziché assicurarle una vita dignitosa, guadagnandosi così tutto l’odio della giovane donna. Dopo sette anni (un numero canonico, che si ritrova in tante fiabe) il marito torna, quasi chiamato dal primo canto della sua sposa dopo tanti anni. Scopre così la verità ed esprime tutta la sua amarezza alla madre per aver tenuto questo comportamento.
Nelle altre versioni della canzone, il finale è molto più forte: sarà la madre che da quel momento dovrà servire la moglie (versione monferrina) o il marito uccide la moglie non potendo uccidere la madre (versione ferrarese). Queste versioni ci danno inoltre degli indizi su cosa potrebbe mancare in quel punto del testo dialettale sostituito dai puntini: probabilmente le parole di rassicurazione della madre al figlio, che avrebbe avuto cura della nuora, ma non possiamo esserne certi.
Non abbiamo inoltre una versione cantata di questa ballata in dialetto reggiano da fare ascoltare ai nostri lettori: forse è andata persa anch’essa o non è mai esistita una registrazione del canto o semplicemente siamo solo noi che non la conosciamo. Esistono però in rete delle bellissime versioni di due ballate piemontesi ( La Bargirola; Aria della Bargirola), e di una ballata provenzale del XIII secolo, nota come La Porcheronne che riprendono il tema della sposa porcaja e ci danno un’idea della bellezza della melodia di questa canzone.