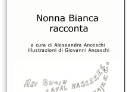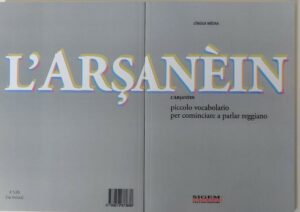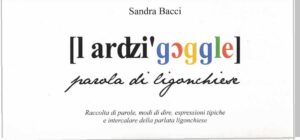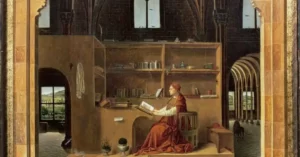
Come aprire in brevità quest’area della nostra OFICINA dedicata al tradurre?
Ci proviamo poiché a nostro modo, e per una piccolissima parte, siamo custodi e garanti di una léngua mèdra che sta molto prima di noi, che abbiamo ricevuto ‘in dote’: parte preponderante, famigliare, dolce e prepotente dei nostri inizi.
Nella léngua mêdra sono custodite le parole con le quali abbiamo iniziato a dare il nome alle cose e ai fatti, udendole e pronunciandole nei primi anni di vita. E che ancora ci trattengono gradevolmente e massicciamente in loro schiavitù di servizio dovendole tramandare, possibilmente –ove è opportuno- anche rinnovandole con nuove ortofonie irriducibili al possesso del pensiero solo razionale.
L’abbiamo già scritto qui nel nostro sito Web: pensare è anzitutto condizionato dal parlare. Nel caso del tradurre da altre lingue in quella mèdra sono disponibili autenticamene sole le parole che si sono ascoltate e conosciute e imparate nella propria lingua. E per questo si può incominciare a parlare con qualsiasi parola fra quelle conosciute.
Dice Bonnefoy che tradurre vuol dire “ aprirsi una strada passando sotto la sua superficie per raggiungere grappoli di significati non esplicitati dall’autore dell’originale; anche per quest’ultimo, molte volte inconsci.”
Tradurre è dichiaratamente ”interpretare”: prendere dei rischi: assumere una serie di decisioni quasi sempre azzardate e audaci, quasi mai meccaniche di traduttori automatici.
Nei tentativi di tradurre in ‘reggiano’ dall’italiano o da altre lingue o dialetti (prove di traduzione nostre e degli amici sempre più vicini), vi è l’atto della ricerca di una parola essenziale che incontra le lingue dalle quali tradurre. E qui in OFICINA e in molte parti del sito, nelle aree: Vever a Res – Paroli Arsani – Scrituri in Arsan , Dialet e Poesia, Il “nostro” Pasolini, risiedono già, destinate a crescere, le traduzioni tentate. Camminiamo fermandoci, senza arrestarci.
Ma tradurre da una lingua scritta in una lingua prettamente orale (com’è nei nostri casi) ove la fonetica diventa rilevante –com’è sempre nelle lingue madri, più legata all’immediatezza dell’esistenza – è un’impresa riproporla, ritraducendola dall’orale/vocale nella forma scritta, secondo una grammatica imparata parlando o o studiando vocabolari e trattati locali, che sono “ il cimitero delle parole” ci ricorda il filosofo Heidegger, poiché qui mancano : la voce, l’intonazione, il contesto, il ritmo, l’emozione, la possibilità della risposta.
Questa perdita della vocalità nei testi in reggiano-emiliano , la contrastiamo bonariamente in léngua mèdra con la nostra pratica: in una trama di scambi vocali, assicurando una continuità di una percezione della vita, grazie ad alcuni componenti fondatori del noster gròp che riportano in vocale una esperienza collettiva che ci ha attraversati direttamente da quasi settant’anni.
Nutriamo perciò la preoccupazione di una verità condivisibile nell’infinità del tradurre scritto e orale, alla quale si chiede uno sfalsamento delle parole rispetto a quelle del testo o della dizione originale, di dire all’incirca le stesse cose: che ricordano a noi lettori ‘di vecchia data’ un saggio di Umberto Eco dal titolo ”Dire quasi la stessa cosa”.
E così chiudiamo questo nostra paginetta, aprendola; ricordando le parole dell’amico e maestro Gianni Scalia, scritte nel foglietto d’inizio del primo numero della rivista “In forma di parole” che ha trattato per quasi trent’anni proprio il tema della traduzione:
Al lettore amico, non possiamo che ripetere una vecchia saggezza: tolle et lege.. Le parole che abbiamo detto, diciamo non ci appartengono più, con preghiera di espropriazione. Ci ritorneranno, in altra forma, come in un dono, in un potlach, in una dèpense ?
Vuol dire nei migliori dei casi, come lo è per noi di lenguamedra : lavorare per dedizione, divertendoci e imparando, nelle horae subsecivae: il nostro privilegiato tempo di vita.