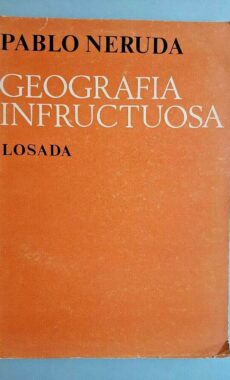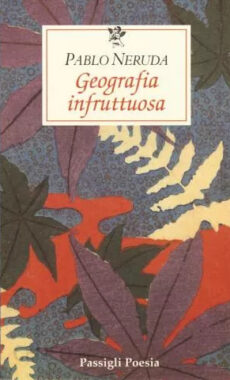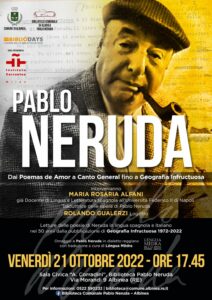
Gian Franco Nasi
Il 21 ottobre 2022, la biblioteca “Pablo Neruda” di Albinea, e Léngua Mêdra, con il patrocinio dell’Istituto Cervantes di Milano, organizzarono un incontro con Maria Rosaria Alfani, professoressa di lettere presso l’Università Federico II di Napoli. Tema dell’incontro: Pablo Neruda – Dai Poemas de Amor a Canto General fino a Geografia infructuosa.
Geografia infructuosa fu l’ultimo libro di Neruda tradotto in Italia prima della sua morte. Le 33 poesie che lo compongono furono tradotte da Maria Rosaria Alfani [1] e pubblicate inizialmente nella rivista letteraria In Forma di Parole, di cui il nostro Rolando Gualerzi è stato curatore.

Spavaldamente, il nostro gruppo di Léngua Mêdra chiese alla professoressa Alfani di indicarci una delle poesie di Geografia infruttuosa da tradurre nel dialetto reggiano. Spavaldamente, perché non conoscendo in anticipo quella raccolta non potevamo immaginare le difficoltà di interpretazione e di traduzione. La professoressa scelse per noi il testo di El sobreviviente saluda a los pájaros (Il sopravvissuto saluta gli uccelli), l’ultima poesia della raccolta.
Era una tipica sfida da affrontare nella sezione Oficina del sito di Léngua Mêdra, questo nostro angolo di sperimentazione in cui sondare, con le nostre limitate capacità, fin dove la nostra lingua madre poteva confrontarsi con altre lingue su tematiche del tutto inusuali.
Occorreva pertanto cercare le fonti critiche e studiare la raccolta nella sua completezza per capirne il senso generale prima di affrontare la versione che ci era stata assegnata. Come in tutte le poesie di Neruda anche in questa il Poeta fece ricorso continuamente all’utilizzo di simboli (animali, oggetti, fenomeni naturali) che richiedono al lettore un intervento di ricostruzione.
Il tempo per affrontare in modo corretto la traduzione non c’era, ma alcuni di noi tentarono l’impresa nonostante l’obiettiva difficoltà di comprensione del testo. La sfida è proseguita sottotraccia e dopo un anno la mia ricerca è approdata qui: la traduzione iniziale non è cambiata molto, ma è certamente migliorata la mia comprensione del testo.
***
Geografia infruttuosa è l’ultimo libro di Pablo Neruda pubblicato quando ancora il poeta era in vita. Un libro importante, dunque, per conoscere il suo stato d’animo in quel periodo per lui particolarmente denso di avvenimenti. Nel 1970, egli assunse l’incarico di ambasciatore del governo cileno a Parigi, a seguito di sua esplicita richiesta, ma ben presto scoprì di aver commesso un errore. L’allontanamento dal suo paese nel momento in cui si concretizzava tra mille difficoltà l’esperienza democratica del governo di Salvador Allende gli provocò una profonda melanconia. Nel 1971, Neruda ricevette il Premio Nobel per la letteratura, ma scoprì anche di essere ammalato di cancro. Visse dunque un periodo segnato dall’ansia, dal pessimismo e dall’angoscia per la vicinanza della morte, sentimenti che emergono in molte delle poesie di Geografia infructuosa.
Inizialmente il titolo del libro era Geografia inconclusa, ma venne poi modificato in Geografia infruttuosa.
Un titolo abbastanza fuorviante, perché
Al termine della raccolta, Neruda aggiunse una dichiarazione importante per capire l’atmosfera generale che pervade il libro.
Le gioie dichiarate da Neruda sono però molto meno delle malinconie.
Come anticipato, Neruda visse in quegli anni il contrasto tra un momento della sua vita che poteva volgere all’ottimismo per l’esaltante stagione politica del Cile di Salvador Allende, così espressa nella poesia Cerezas/Ciliegie:
E’ stato in quel mese, in quella patria/. C’è stata una vicenda inaspettata, / è accaduto così: da un giorno all’altro/ quel paese s’è riempito di ciliegie./……../ Di ciliegia in ciliegia cambia il mondo./ (in: Ciliegie/Cerezas)
e l’angoscia che lo invase alla scoperta di essere ammalato di cancro. L’annuncio di questo male venne dato da Neruda con questi versi in El codarde:
E adesso mi duole l’anima e tutto il corpo/ e grido e mi nascondo nel pozzo/ dell’infanzia, con paura e vento forte:/ oggi che il sole giovane dell’inverno/ ha portato una goccia di sangue, un segno amaro./ tutto è finito ormai: non c’è scampo,/ non c’è mondo né bandiera promessa:/ basta una ferita per abbatterti:/ con una sola lettera/ ti uccide l’alfabeto della morte/ un solo petalo del gran dolore umano/ cade nella tua orina e credi/ che il mondo intero si dissangui./
Molte delle poesie di Geografia infruttuosa sono pertanto percorse dalla ricerca (infruttuosa) del senso ultimo della vita, da interrogativi senza risposta:
E perché tanti fiori, tanta vasta/ stirpe vegetale che innalza/ stami, polline, luci, insetti, luna/ ei nostri piedi, le nostre bocche piene/ di parole, di polvere/ che svanisce,/ qui imbarcati, qui maturati/ in piena deliziosa luce di cielo?/ E perché? A quale scopo? Ma perché? (Ma forse /Pero talvez).
***
La poesia El sobreviviente saluda a los pajaros
Fundé con pájaros y gritos de sol la morada:
temprano a la hora del manantial, salí al frío
a ver los materiales del crecimiento:
olores de todo y sombra, medallas que la noche dejó
sobre los temblorosos follajes y la hierba.
Salí vestido de agua, me extendí como un río
hacia el horizonte que los más antiguos geógrafos
tomaron como final del presupuesto terrestre:
yo fui entre las raíces, bañando con palabras
las piedras, resonando como un metal del mar.
Hablé con el escarabajo y aprendí
su idioma tricolor, de la tortuga
examiné paciencia convexa y albedrío, encontré
un animal recién invitado al silencio:
era un vertebrado que venía de entonces,
de la profundidad, del tiempo sumergido.
Tuve que reunir los pájaros, cercar
territorios a fuerza de plumajes, de voces
hasta que pude establecerme en la tierra.
Si bien mi profesión de campana
se probó a la intemperie, desde mi nacimiento
esta experiencia fue decisiva en mi vida:
dejé la tierra inmóvil: me repartí en fragmentos
que entraban y saltan de otras vidas,
formé parte del pan y la madera,
del agua subterránea, del fuego mineral:
tanto aprendí que puse mi morada
a la disposición de cuanto crece:
no hay edificación como la mía en la selva,
no hay territorio con tantas ventanas,
no hay torre como la que tuve bajo la tierra.
Por eso, si me encuentras ignominiosamente
vestido como todos los demás, en la calle,
si me llamas desde una mesa en un café
y observas que soy torpe, que no te reconozco,
no pienses, no, que soy tu mortal enemigo:
respeta mi remota soberanía, déjame
titubeante, inseguro, salir de las regiones
perdidas, de la tierra que me enseñó a llover,
déjame sacudir el carbón, las arañas,
el silencio: y verás que soy tu hermano.
Neruda aveva già scritto anni prima una poesia dal titolo simile, El poeta se despide de los pájaros (Il poeta dice addio agli uccelli), dal tono completamente diverso da quest’ultima. Qui il termine “sopravvissuto” sostituisce il termine “poeta”: un cambiamento che riflette lo stato d’animo di Neruda. Si sente come un sopravvissuto, ma sa di avere ancora poco tempo da vivere e in questa poesia fa una sintesi della sua vita e dei timori incombenti, primo fra tutti quello di restare solo e dimenticato.
Perché gli uccelli? Uno dei grandi hobby di Neruda era l’ornitologia. Scrive Neruda in Para nacer he nacido:
Dagli uccelli Neruda ha imparato il canto, la sua arte: per questo li sente amici e a loro deve un suo (estremo) saluto. Agli uccelli ha dedicato anche un poema (Arte degli uccelli, 1966) e in una sua poesia immaginò di essere lui stesso un uccello (El pàjaro Yo). Un uccello molto speciale, fatto di una singola piuma, con la quale descriveva la vita e denunciava i suoi cacciatori, tutte quelle persone che volevano mettere a tacere il suo canto. Ma per Neruda, gli uccelli sono forse anche una metafora degli uomini che amano la libertà e che gli sono stati amici. Non a caso, nel poema, inventa la categoria dei “pajarantes”, ossia volatili inventati dal poeta con le loro definizioni latine pseudoscientifiche che rappresentano quasi esclusivamente figure di amici o persone care. Così, si può interpretare che il “saluto” agli uccelli sia anche un saluto agli uomini con una accorata richiesta espressa nell’ultimo verso della poesia.
Il sopravvissuto saluta gli uccelli
Con uccelli e grida di sole ho fondato la dimora:
presto, all’ora della sorgente, sono uscito al freddo
a vedere i materiali della crescita: odori
di fango e ombra, medaglie che la notte ha lasciato
sulle foglie tremolanti e sull’erba.
Vestito d’acqua mi sono allungato come un fiume
verso l’orizzonte che i più antichi geografi
presero a termine del calcolo terrestre:
sono andato fra le radici, bagnando di parole
le pietre, risuonando come un metallo marino.
Ho parlato con lo scarabeo e ne ho imparato
I ‘idioma tricolore, della tartaruga
ho studiato la pazienza convessa e l’arbitrio, ho trovato
un animale da poco invitato al silenzio:
era un vertebrato che veniva da allora,
dalla profondità, dal tempo sommerso.
Ho dovuto riunire gli uccelli, recintare
territori a forza di piumaggi, di voci
finché potei stabilirmi sulla terra.
Sebbene la mia professione di campana
s’è formata alle intemperie, dalla mia nascita
quest’esperienza è stata decisiva nella mia vita:
ho lasciato la terra immobile: mi sono sparso in frammenti
che entravano e uscivano da altre vite,
sono stato parte del pane e del legno,
dell’acqua sotterranea, del fuoco minerale:
tanto ho imparato che la mia dimora è stata
a disposizione di tutto quel che cresce:
non cè costruzione come la mia nella selva
né territorio con tante finestre,
né torre come quella che bo avuto sottoterra.
Perciò, se mi trovi ignominiosamente
vestito come tutti gli altri, per strada,
se mi chiami da un tavolino in un caffe
e noti che sono goffo, che non ti riconosco,
non pensare, no, che sono il tuo mortale nemico:
rispetta la mia remota sovranità, lasciami
titubante, insicuro, uscire dalle regioni
perdute, dalla terra che m’ha insegnato a piovere,
lascia che mi scrolli il carbone, i ragni,
il silenzio: vedrai che sono tuo fratello.
Al scampê al salóta j usê
Con usê e l aghiê dal sòl a j ò fundê la cà:
ed bunòura, a l’ōra d l’alvêda, sun andê fôra al frèd
a vèder i materiêl dla costrusiòun: udōr
ed pantân e òmbri scûri, mdâj che la nôt l à lasê
in sem’al fòj termulèinti e in sem’a l’êrba.
Vistî d acva am sûn slunghê cme un fiòm
vêrs i cunfîn dal mònd dove j piò antigh sapijnt
îven piantê i pilâster per amşurêr la tèra:
sûn andê fra al raîşi, bagnând ed parôli
al prēdi, vibrând cme una campana ‘d mêr.
J ò parlé cun la Cetonia e a n’ ò imparè
la parlêda d trî culōr,
j ò studiê la pasînsia gôba e al giudési dla bésa scudlêra,
j’ò catê un èser da pôch invidê al silèinsi:
un vertebrê ch al gnîva d’ alōra,
da la profonditè, dal tèimp şòt âcva.
J ò dvû arduşîr j usé, cuntgnîr
di sît a fôrsa ed piómi, ed vòusi
fintânt ch j ò prû stêr sòuvra la tèra.
Ânch se la mé profesiòun ed campâna
la s’ ē fâta a l’albaraja, da quând sun nasû
còsta sperijnsa l ē stêda decişîva indla mé véta:
j ò lasê la tèra fèirma
am sun semnê in pès
ch’andeven dèinter e fōra da êtri véti,
sûn stê pêrta dal pân e dal lègn,
dl’aqua ascòuşa, dal fôgh minerêl:
tânt j ò imparê che la mé cà l ē stêda
bòuna per tót còl ch a crès:
an gh ē costrusiòun cme la mìa in dla buscâja
né trèin cun tânti fnèstri,
né tòra cme còla avûda sòt tèra.
Per còst, se t ém cât orendamèint
vistî cme tót ch j êter, per strêda,
se t ém cîam da un tavlèin in un café
e t ém vèd şvêrs, ch an t’arcgnòs mia,
an pinsêr mia, nò, ch a t sûn nemîgh murtêl:
rispèta la mé luntâna sōvranitê, lêsom
indecîş, pôch sicûr, gnîr fôra dal regiòuni
pêrsi, da la tèra ch l a m à insgnê a piōver,
lêsa ch a mé squâsa via al carbòun, i râgn,
al silèinsi: at vedrê che sun tó fradèl.
La prima strofa parla della prima fase della vita del poeta, del momento in cui sentì sorgere in lui l’amore per la poesia, qui definita come la sua “dimora”.
Maria Rosaria Alfani, nella Prefazione a Geografia infruttuosa, scrive:
In questa strofa, Neruda utilizza la figura retorica della personificazione nell’espressione “le grida di sole”, che possono essere pensate come un incitamento, un pungolo per dar voce alla sua poesia. Per questo si è scelto di tradurre “gritos de sol con aghiê dal sòl, ricordando che l’ aghiéera il pungolo con il quale il contadino stimolava i buoi. L’espressione all’ora della sorgente va probabilmente interpretata come il momento in cui in Neruda scaturì la passione per la poesia. La traduzione con il termine alvêda è utilizzato per indicare il sorgere del sole, il momento in cui sorge un nuovo giorno e, metaforicamente, una nuova vita illuminata dalla poesia.
Questo avvenne ben presto nella vita del Poeta, quando viveva nella città di Temuco, nel sud del Cile dove il clima era freddo e piovoso, come scrisse in Ode al sole:
“Non conoscevo il sole./ Ho vissuto in inverno/. Era /nelle Montagne del Sud./ Le acque/ invadenti/ sostenevano/ la terra/, il cielo era/ un pallido ombrello/ traboccante/, una medusa/ oceanica/ dai capelli verdi./ Pioveva/sul soffitto,/ sulle foglie nere/ della notte,/scendeva/ acqua celeste/ dalle sdentate/ brezze.”
L’acqua di Temuco diventa metaforicamente l’abito di Neruda per far fluire il suo canto (allungato come un fiume) ovunque (fra le radici e le pietre), nominando ed enumerando le cose (bagnando di parole), ne ha esplorato le profondità (risuonando come un metallo marino), ha dato voce a linguaggi sconosciuti (l’idioma tricolore dello scarabeo), ha ascoltato gli insegnamenti del mondo naturale (la pazienza convessa della tartaruga e l’arbitrio). Due termini non corrispondono alla traduzione letterale. Sono Cetonia, nome comune di una sorta di scarabeo dorato, qui utilizzato al posto di scarabeo; vertebrê per vertebrato (in dialetto si potrebbe dire “schîna dréta”?) (sic!).
A questo punto della poesia compare infatti un “animale vertebrato venuto dal tempo sommerso e da poco invitato al silenzio” di non facile comprensione. La Prefazione di Maria Rosaria Alfani è di aiuto nella comprensione di questo passo. In un’altra poesia della raccolta (Soliloquio incompiuto), Neruda parla dell’esistenza di un altro se stesso, un io rimosso.
Scrive Maria Rosaria Alfani:
Pertanto, “l’animale vertebrato” può essere interpretato come questo io rimosso che ha convissuto con il Poeta per tutta la vita (da allora, dalla profondità, dal tempo sommerso). Nella traduzione in dialetto è parso opportuno utilizzare il termine essere (èser) al posto di animale (bèstia).
Anche il testo della quarta strofa è di difficile comprensione. Si potrebbe pensare forse ad un proseguimento della metafora del primo verso della poesia, per cui quel riunire gli uccelli fosse, ogni volta, l’operazione preliminare per ogni nuova raccolta di poesie; e quel recintare territori a forza di piumaggi la concreta realizzazione di quelle opere, che gli consentirono di essere tra gli uomini, di entrare a far parte della loro vita.
Nella quinta strofa Neruda afferma con orgoglio il valore del suo lavoro, l’originalità della sua poesia, la sua professione di campana. La campana è un simbolo ricorrente nell’opera di Neruda anche se il suo significato può essere di volta in volta diverso e “sta al lettore non trasformare [i simboli] in semplici chiavi, in elementi di equivalenza e di scambio, ma lasciarli dove li ha messi il poeta e lasciarsi invadere dalle loro risonanze ben al di là delle equivalenze razionali»[3]. L’arte del Poeta consiste nel far risuonare le parole, evocare delle emozioni, così come una campana fa risuonare e vibrare il suono. Qui sembra logico assegnare questo simbolo alla Poesia, formatasi, in senso figurato, alle intemperie di Temuco o, fuori metafora, all’ostilità di molti nemici di Neruda, per la sua fede politica. Tutta la strofa è una affermazione della identità del Poeta da lui stessa consegnata a chi verrà dopo di lui. I versi di questa strofa hanno fatto parlare di ego-pantetismo di Neruda:
Anche qui abbondano i simboli: riappare la sua dimora del primo verso, a disposizione di tutte le creature, che fa pensare alle Odi elementari dedicate alle cose apparentemente più insignificanti (la cipolla, il carciofo, gli uccelli…); le “tante finestre” (simbolo di apertura verso il mondo e di trasparenza); la torre che ha avuto sottoterra (?).
Nella sesta strofa, infine, Neruda riprende un tema presente in altre poesie della raccolta, quello dell’identità di ogni essere umano all’interno della successione temporale, e lo stupore che gli individui conservino la loro unità, nonostante la frammentazione causata dall’intermittenza dei giorni:
La parola d’ordine della vita è «morte all’identità» (Successivo); i corpi si succedono uguali, e l’uomo è un continuo ripetersi:
Quel che la vita ha di successivo/ è l’andare e venire degli uguali:/ Morte all’identità, dice la vita:/ ognuno è l’altro, e ci congediamo/ da un corpo per invaderne un altro.
E la mancanza di identità è favorita dalla meccanica del mondo che trasforma gli uomini in numeri (Contiamoci):
ci ammucchiano in numeri che rapidi/ da quei registri cadono nell’oblio./ Io mi chiamo trecento,/ quarantasei o sette,/ con umiltà regolo conti/ per arrivare a zero e congedarmi.
Qui, alla fine dell’opera, Neruda afferma la sua identità di poeta, e quell’io sacrificato riemerge dalle regioni perdute, dalla terra che gli ha insegnato a vivere come uomo tra gli uomini, parte inseparabile della collettività umana. La vita che sarebbe continuata dopo la sua morte era anche la sua stessa vita. Concluse il discorso tenuto in occasione dell’evento con cui il Paese lo accolse al suo ritorno dall’Europa, alla fine del 1972, proclamando che la vita, la lotta e la poesia avrebbero continuato a vivere quando lui sarebbe stato solo un piccolo ricordo.
Bibliografia
[1] Pablo Neruda, Geografia infruttuosa, Prefazione e traduzione di Maria Rosaria Alfani. Passigli Editori
[2] Óscar Hahn: El infructuoso clamor de Pablo Neruda, Estudios Públicos, 94 (otoño 2004)
[3]Luz Elena Zamudio Rodríguez, Pablo Neruda y el tierno sonido de su campana rota, Signos literarios 14 (Julio-Diciembre 2011) 133-150
[4] https://cultura.fundacioneruda.org/2023/09/29/capitulo-4-legado-y-vigencia-de-pablo-neruda/