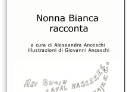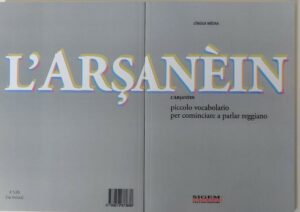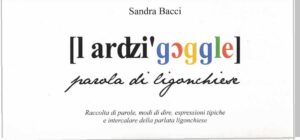Setèmber, 2022
In queste settimane, nelle cantine reggiane si sta preparando il vino nuovo. Dedichiamo allora questo appuntamento mensile con la rubrica del dialetto reggiano al lambrósch. Da dove proviene questo nome?
Quando si cerca l’etimologia di una parola si entra in un campo minato, tante possono essere le spiegazioni che vengono proposte dai letterati, ed è così anche per il lambrusco. Noi, che non siamo esperti in materia, vogliamo presentare quelle che abbiamo reperito in letteratura, lasciando ad ogni lettore la scelta di quale gli sembra più plausibile.
Il termine labrusca o labruscum venne citato da Plinio il Vecchio (23-79 d.C) nel XIV Libro della Naturalis Historia per indicare una specie di vite selvatica. Non sappiamo però, è bene precisare, se il nostro lambrusco derivi veramente da quelle stesse specie di viti selvatiche citate secoli prima da Plinio o se, nel corso dei secoli, quel nome sia stato utilizzato per un vitigno diverso.Secondo Ottorino Piangiani, cultore di linguistica e autore di un (criticato) Vocabolario etimologico della lingua italiana (1907), questo termine deriverebbe dalla fusione di due parole: dal latino labrum (orlo, bordo, margine), perché le viti selvatiche crescevano ai margini o alle estremità dei campi, dove finivano le colture o, in alternativa, dal greco labo (prendo) perché la vite è un rampicante che si attacca agli altri alberi; ruscus, dal nome latino di un arbusto pungente, ben noto con il nome di pungitopo, perché l’uva di quelle viti selvatiche pungeva il palato. Da questo termine deriverebbe anche la parola brusco, col significato di cosa dal sapore asprigno.
Un’altra possibile spiegazione, molto interessante, è riportata nel DESLI–Dizionario Etimologico semantico della lingua italiana (Pendragon, 2015) di due eminenti studiosi, Mario Alinei e Francesco Benozzo.
Secondo questi autori, il termine lambrusco deriverebbe sì dal latino labrusca, ma questo a sua volta sarebbe collegato al latino rusca/brusca, con il significato di ‘immondezzaio’ (da cui le forme dialettali emiliane del tipo rósch e ruscarōla per indicare “immondizia, immondezzaio, pattumiera”). Questa correlazione si spiegherebbe con la teoria di alcuni archeologi secondo la quale gli immondezzai preistorici, legati ai primi nuclei abitativi del Neolitico, in seguito all’accumularsi in essi di semi, frammenti di radici e organi vegetativi, diventarono col tempo delle specie di aiuole seminate, uno degli ambienti ai quali è possibile far risalire la prima domesticazione della vite selvatica.
Qualunque sia la vera origine della parola lambrósch, dopo aver citato tanta scienza, ci concediamo un po’ di relax con alcuni versi dell’Elogio del Lambrusco di Rolando Cavandoli:
A l’òst o in ca’ o in parèint, ovunque sía,
un bòun bicér d’ Lambrósch l’é còl ch’agh vôl:
al t’arsòra, al t’arbóssa, al t’dà alegría,
al s’cióma, al brélla, al canta c’me n’us’gnol.
S’et gh’èe tristèzza, lo l’ t’ la càza via,
s’a pióv o nèiva, lo l’fa gnir al sól.
…….
Quand al Lambrósch al canta, lev’t’ in pée,
vóda al bicér dòu vòlti e torn’g’ adrée.