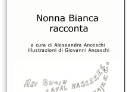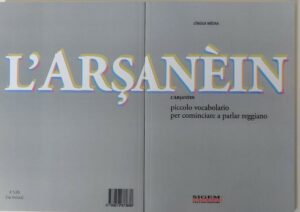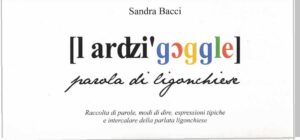Il 13 maggio 1978 viene approvata la Legge 180 per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici, ormai universalmente nota come “Legge Basaglia” che è stata la prima legge al mondo a disporre la chiusura dei manicomi e l’Italia resta a tutt’oggi l’unico paese ad avere attuato in modo così radicale questo processo.
Con questa legge sono stati chiusi gli ospedali psichiatrici italiani e l’assistenza psichiatrica si è spostata sul territorio, nella comunità. Mentre l’internamento in manicomio sanciva l’esclusione sociale dei pazienti, da oltre quarant’anni ormai la società Italiana riconosce che anche le persone sofferenti psichiche hanno pari diritti degli altri cittadini e che anche per loro non vi può essere cura senza inclusione sociale. Il contrario di ciò che poteva offrire la vita in manicomio, chiusa all’interno delle sue mura.
Franco Basaglia ci ha lasciato nel 1980, poco più che cinquantenne, e lo ricordiamo con riconoscenza con alcune sue citazioni significative del suo percorso di psichiatra “illuminato”.
<< La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d’essere.>>
<< Per me, che si parli di psicologo o di schizofrenico, di maniaco o di psichiatra è la medesima cosa: sono tanti i ruoli, all’interno di un manicomio, che non si sa più chi è il sano o il malato.>>
<< Aprire l’Istituzione non è aprire una porta, ma la nostra testa di fronte a “questo” malato…>>

La definizione di Cà di Pòm (casa delle mele) comunemente utilizzata a Reggio per indicare il San Lazzaro, origina dal periodo della prima guerra mondiale, nel quale il San Lazzaro tra il 1917 e 1918 ospitò intorno ai cinquemila soldati, la maggior parte dei quali, per ragioni igieniche erano “rapati” a zero. Da fuori le mura si vedevano quindi un gran numero di teste calve aggirarsi all’interno, da qui La Cà di Pòm.
Fondato su di un antico lebbrosario del 1217, il San Lazzaro diviene prima ricovero per appestati, poi ospizio per poveri e mendicanti e dal 1536 per malati di mente. E’ nelle prime decadi del 1800 che l’Istituto evolve a vera e propria casa di cura mentale fino ad acquisire una certa fama europea intorno al 1850. Il San Lazzaro diviene quindi uno dei più importanti Manicomi italiani e negli ultimi 150 anni di attività ha accolto circa 100.000 ricoverati.
Oggi l’ormai ex San Lazzaro ospita la Biblioteca Scientifica Carlo Livi, che fu direttore dell’Istituto dal 1873 al 1877 anno della sua morte, e che la istituì in quegli anni. La biblioteca dispone di un patrimonio archivistico di importanza assoluta nel panorama italiano, poiché conserva una ricca testimonianza di ogni aspetto della vita e della gestione dell’istituto, il cui aspetto principale è costituito dalle cartelle cliniche, raccolte sistematicamente dal 1871 in poi.


Nel 1921 viene costituita la Colonia-Scuola dedicata al medico sociologo piemontese Antonio Marro, e voluta dal direttore Guicciardi per l’educazione dei bambini definiti allora arretrati o anormali. Questa si rivela un’esperienza importantissima per dare istruzione ed un posto nel mondo e nella vita a tanti bambini sfortunati che spesso erano “anormali” solo nell’ambiente e nelle condizioni da cui provenivano. Già nel 1931 il reparto venne dotato di una palestra e di laboratori artistici ed artigianali.
Alcuni di noi ragazzi settantenni ricordano ancora come appunto da bambini all’Ospizio per dare dello stupido ad un altro bambino gli si diceva “mó và al Marro”.

La direzione di questo reparto del San Lazzaro in cui i bambini venivano curati soprattutto tramite ergoterapia, viene affidata nel 1922 a Maria Bertolani Del Rio. Nell’ambito di questo progetto, fra il 1928 e il 1935 la scienziata condusse l’esperienza dell’ Ars Canusina, tecnica che deve il suo nome alla figura di Matilde di Canossa, della quale la Del Rio sarà appassionata per tutta la vita, e che consisteva nella riproduzione su diversi materiali di motivi ornamentali tipici dell’arte romanica preventivamente selezionati e raccolti nell’album Ars Canusina da lei pubblicato nel 1935.